La mia vita con Luciano
Nel ’74, a tre anni dalla sua morte, ho scritto Tutto d’un fiato, una sorta di cartella clinica, di trascrizione delle chiacchierate con un amico psicanalista milanese, un’immersione nella memoria più lontana e in quella più recente, ancora troppo viva e dolorosa. Oggi, passati tanti anni, le cose sono cambiate, la mia biografia si è arricchita di altre esperienze, di altri incontri importanti che hanno contribuito a ricostruire, faticosamente, un equilibrio stabile, fondato sulla fiducia, sulla solidarietà, sul rispetto.
Ma il processo è stato durissimo e lungo, non privo di intoppi, errori, crisi, cadute. Uscire dallo sbalordimento, dall’annichilimento di una vicenda fatale, irreparabile, violenta e bellissima, vissuta allo stremo, e riprendere a camminare affidandomi con cattiva coscienza all’ausilio – illusorio, pretestuoso – di un sostegno inadeguato, di una gruccia difettosa, è stata la prova peggiore della mia vita. Ma bisognava farcela. C’era, adolescente disorientato, mio figlio. Suo figlio. Nostro figlio. Marcello. Frutto illegittimo dell’unione illegittima tra una donna libera e uno scrittore famoso morto a quarantanove anni per “non aver appreso abbastanza il Mestiere di vivere ed essersi fatto scivolare fuori dall’esistenza”. La vanità della vita, del successo, il rifugio nell’alcol non sono bastati – non potevano – ad alleviare un peso troppo grande, ad arrestare “la lunga discesa agli inferi”.
Una storia difficile. A ripercorrerla dopo più di mezzo secolo c’è da domandarsi come sia stato possibile reggere per tanti anni l’urto devastante dei sensi di colpa, dei ripensamenti, delle accensioni furibonde, delle nostalgie, delle mitizzazioni inevitabili. Un grande amore. Certo. Esaltante. Burrascoso. Romantico. Dannunziano è stato detto e scritto, con larga profusione di retorica. Un grande amore in un grande contesto. Un mondo che cambiava, un paese povero emigrante e contadino che si faceva le ossa, diventava adulto, provava a inserirsi nel consesso di realtà più avanzate dove coppie come la nostra non venissero additate, perseguite penalmente, dove procreare, o non, fosse una scelta libera, cosciente, responsabile, sottratta alla vergogna e all’umiliazione della clandestinità. Essere dentro questo contesto con la voglia di cambiare il mondo a cominciare da noi stessi, dalla nostra vita, questa era la scommessa.
Io, comunista, fanatica e settaria /…/ ma senza cattiveria dottrinaria, figlia di comunisti confinati, nipote di socialisti bastonati, la lotta ce l’avevo nel sangue e l’affrontavo a capofitto accettandone le conseguenze: la spavalderia di finire alle Mantellate, di essere manganellata dai poliziotti di Scelba, additata dai piccoli borghesi del palazzo, del quartiere: Garbatella. Roma. La presunzione di essere diversa e dalla parte giusta. La parte dei rivoluzionari, di quelli che avrebbero costruito il mondo nuovo. Questo era il mio orgoglio quando lo conobbi, una sera d’estate del ‘50, a Livorno. Lui che recita un epitaffio da Spoon River, i nostri occhi che si agganciano: il respiro del mare, le parole, la letteratura, l’amore… Ma a Grosseto c’era già Ettore e c’era Mara – la foto in costume da bagno nel portafogli – una brava ragazza, belloccia, tranquilla, semplice, tutta dedita alla
sua vita grigia e a suo modo eroica, fatta di mille gesti eguali e dimessi, fedele giorno per giorno alla sua scelta, al dovere, ai luoghi./…/ Era giusto che io, amico degli umili e dei diseredati, alleato per mia scelta della classe operaia, eversore in pectore di torracchioni, umiliassi e diseredassi questa donna?
E così, dopo un tempo febbrile di lettere e di fughe, la nostra bella storia finisce nel cassetto. Io libera per la mia strada: il partito, il lavoro alla cgil di Di Vittorio, le passioni, i libri, le prime prove di scrittura, il cinema… Lui, la famiglia, la messa alla domenica con le donne, il bordello al sabato con gli amici, la biblioteca, il cineclub, il bibliobus per gli operai, i minatori della Maremma… Ma poi succedono le cose più grandi di noi, le cose che ci cambiano, che ci mettono imperiosamente di fronte alla realtà, ai massimi interrogativi, alle scelte dalle quali non si torna indietro. Maggio ’54, Ribolla:
quarantatré morti, tanti fagotti dentro una coperta militare, /quarantatré bare/, ciascuna con sopra l’elmetto di materia plastica, e in fondo le bandiere rosse. /…/ Mi ritrovai solo sugli scalini dello spaccio /…/ e mi sembrò impossibile che fosse finita, che non ci fosse più niente da fare.
Quarantatré cavatori, scarriolanti, barellieri… Comunisti, anarchici. Amici. Persone, padri di famiglia, morti per quattro soldi di fame. Non si può. Non si deve. Bisogna cambiare, bisogna costruire un mondo più giusto. Lui viene a Roma. È gonfio di dolore e di rabbia. Vuole vedermi, ritrovarmi, parlare con me, pensare all’avvenire. Noi due, insieme, per spaccare il sistema, dare senso alla vita. Buttare a mare tutto ciò che è vecchio, sbagliato, impotente, borghese. Questo è l’imperativo. L’occasione è Feltrinelli,. Milano. Convocato dal pci, lui, che non ama i politicanti, è incerto, confuso mentre io, tetragona, non ho dubbi: Milano è la svolta decisiva e lo esorto ad accettare. Far parte della redazione della nascente casa editrice significherà per noi allontanarci: Milano è molto più distante di Grosseto, un altro mondo, un’altra Italia. Ma ciò che conta è dare un nuovo corso alla sua vita. So con certezza che uno come lui non può, non deve continuare a catalogare e prestare libri o a organizzare il lavoro culturale nella “meraviglia-trappola” della provincia.
Milano è la grande avventura. È lì che si fa la rivoluzione. È lì che accade tutto, che si decide tutto. È lì che bisogna stare.
Di qui sarebbe nata la solidarietà, di qui il modo della riscossa, un milione e mezzo di formiche umane da stringere e scatenare contro i torracchioni /…/ contro i padroni /…/ contro i loro critici tirapiedi, e fare piazza pulita d’ogni ingiustizia, d’ogni sporcizia, d’ogni nequizia.
Per quasi un anno io nella mia città, il lavoro, il partito, la lotta, il primo aborto, qualche scappata al Nord nei week end: otto nove ore di treno notturno, puzzo di piedi e di miseria. Disagi, fatica e felicità. Lui, lassù, il lavoro, le fughe a Roma. Una volta non torna in tempo, si dà malato, ma qualcuno ci vede insieme e lo racconta al padrone. Licenziato.
Febbraio 1955, nove mesi dopo quel giorno di maggio, salgo a Milano, definitivamente. La stanzetta gelida di via Solferino. La Braida, il bar delle Antille…Tanta miseria. Tanto amore. La vita è dura. Si mangia quasi nulla, le notti sono bianche, il giorno si lavora dieci dodici ore: qualsiasi cosa. Le entrate smunte divise in due: metà laggiù, alla famiglia vera, metà per noi, che una vera famiglia non siamo e sfidiamo la legge. Noi due
scalmanati, lui in mongomeri senza cravatta e con la barba lunga, lei con addosso quei coloroni e quelle gonnellone ampie e il fazzoletto rosso legato alla gola. Tipi da non fidarsi, perdigiorno, senza una lira in tasca, sicuramente
Lui che gira di notte, da solo, la barba lunga, gli occhi gonfi, lui che cammina lentamente, si ferma, torna indietro. Lui che strascica i piedi, si muove piano, si guarda attorno con aria sospetta, lui che non marcia, non solleva polvere, non si difende
dal traffico astioso delle auto, dall’esercito dei ragionieri assonnati in camicia bianca e occhiaie bluastre e delle segretariette , che corre corre corre per fare i dané.
Noi irregolari, anomali, esaltati, che un figlio irregolare, Marcello, lo avremo più tardi, quando sarò io a volerlo con tutte la mia determinazione. Dovranno passare più di tre anni. Intanto laggiù è nata Luciana, frutto di una vacanza in famiglia. Tra una cosa e l’altra…
A Milano la vita è dura e la rivoluzione si allontana. Io non sono più altro che la Maria del Bianciardi. La mia libertà, la mia fierezza, il mio orgoglio, il mio sogno, la mia utopia sono ricordi logorati dalle difficoltà oggettive, materiali e morali. La nostra è una storia colpevole, travagliata, senza pace, rosa all’interno da dubbi e rimorsi.
A volte mi sembra di aver tradito la mia città, voi amici, le mie origini […] Non dovevo scappare.
Dove sono finiti gli entusiasmi, i propositi alti? Dov’è la lotta contro ingiustizie, nequizie sporcizie. Dov’è l’orgoglio, lo slancio rivoluzionario?
La rivoluzione deve cominciare da ben più lontano, deve cominciare in interiore homine
Cambiare noi stessi per cambiare il mondo, dicevamo. Ma la pesantezza del quotidiano ha spezzato il volo. Che fare?
Bisognerebbe fare la rivoluzione, ma non si trova seguito… Insomma, cosa è oggi la classe operaia, e il partito? Dov’è lo sbaglio? Era sbagliato il nostro operaismo di allora, oppure sono cambiati anche gli operai?
Dove s’è consumata la passione civile, politica?
La politica /…/ ha cessato /…/ di essere scienza del buon governo, ed è diventata invece arte
della conquista e della conservazione del potere.
Il mondo sta cambiando per conto suo, velocemente. La rivoluzione può attendere. Bisogna cercare di adeguarsi, capire.
In quegli anni si parlava moltissimo di automazione, di produttività, di seconda rivoluzione industriale e di umane relazioni. Pareva che tutti i rapporti, produttivi e umani, dovessero cambiare, mentre poi hanno ricominciato – e forse non avevano mai smesso – a prendere gli operai/…/ a calci nel culo.
Insomma, la vita è dura. La vita è agra.
Mi hanno ridotto che a fatica mi difendo /…/ e la forza che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche, e se riesco a campare, credi pure che la vita è agra, quassù.
Le cose vanno un po’ meglio con l’uscita de La vita agra. Il successo che ne verrà ci affranca dalla miseria, ma ci divide. Qualcosa s’è spezzato. Dentro. Fuori è tutto come prima, con un po’ di bugie in più, un po’ di soldi in più, un po’ di notorietà e di vita mondana in più.
L’aggettivo agro sta diventando di moda, lo usano giornalisti e architetti di fama nazionale. Finirà che mi daranno uno stipendio solo per fare la parte dell’arrabbiato italiano.
La mia insofferenza per la nuova vita che ci allontana, mi spinge a fuggire con Marcello. Riviera ligure. Rapallo. L’alibi è la salute del bambino, il mare. Una grande casa nella quiete di un piccolo borgo silenzioso, riparato dalla folla ossessa. Tanto lavoro, tanti bagni o in giro per i dolci colli. Lui ci raggiunge periodicamente, poi, stanco del ménage pendolare, chiude con Milano, via Domenichino, e coi viaggi all’alba. Inizia l’esilio di Nesci. Qualche parentesi di spensieratezza, qualche viaggio: New York, Israele, il Maghreb, Mosca…
Quando arriva la valanga liberatoria del ’68, riprendo con entusiasmo il mio posto nella lotta, nel pci, a Genova, coi portuali e con gli studenti. Incontro Dario Fo e il suo teatro politico, amoreggio con la sinistra extraparlamentare. Luciano ha ritrovato in qualche misura il passo e la dimensione provinciali: le lunghe camminate, le chiacchiere, le bevute coi vitelloni locali… Grosseto/Kansas City è lontana come un mito, un’utopia. Presente come un male subdolo che mina anima e corpo.
È il tempo del progressivo isolamento, del ricorso sempre più massiccio all’alcol, della solitudine. Delle porte chiuse, della mascherina sugli occhi, dei tappi di cera nelle orecchie, della bottiglia sul comodino, della bestia nello stomaco. In questo contesto matura il proposito di tentare un rientro a casa, dai figli. Qualsiasi decisione ne deriverà, sono pronta a condividerla. Lui lo sa e me ne è grato. Ma il recupero di una paternità tardiva, colpevole e sofferta, per esiti diversi e opposti, si traduce in un disastro oscuro e irreparabile. La vicenda si protrae per alcuni mesi di pendolarismo prima di franare drammaticamente. Il mito è sgretolato e sepolto.
Siamo nel 1970. La salvezza – il miraggio – è per me ancora una volta Milano. Ricominciare, ostinatamente, disperatamente. Riprendere una vita normale, attiva, tra la gente, gli intellettuali, gli amici. I miei cari amici che non mi hanno mai abbandonata.
A Milano non ho amici […] mi sono fatto duro, non amo più la compagnia del prossimo, e sento che l’antica vena ironica sta diventando cattiveria.[…] Vedo poca gente […] I rapporti col prossimo si riducono sempre più al chiedere e al dare, tanto per tanto.[…] Non c’è solidarietà, solo omertà, cricca, mafia, società d’affari…
Ma ancora una volta la mia è un’illusione. Ancora una volta usci sbarrati, notti tormentate, insonnie cattive, claustrofobia, alcol, barbiturici, torpore ipnotico, alternanza di momenti di sovreccitazione nervosa e momenti di profonda depressione, esplosioni di collera, allegrezze isteriche, cupaggine, silenzi. Odore di morte…
Malato, continua tuttavia a lavorare: collabora a vario titolo con numerose testate, scrive una biografia di Garibaldi, che uscirà postuma, un testo risorgimentale per ragazzi, un diario collettivo a quattro mani su un viaggio nel Magreb, e cura perfino la riduzione cinematografica di un suo racconto, concedendosi la vanità di una breve apparizione nel film. Ma nulla basta. Nulla vale a uccidere il mostro.
Non ci posso fare nulla. Quel che potevo l’ho fatto, e non è servito a niente.
L’impotenza, la sconfitta, il fallimento di tutti gli strumenti messi in atto – tra cui la psicoterapia per interposta persona – per non soccombere, per evitare l’inevitabile. Nulla basta. Sappiamo entrambi che è finita. Per esaurimento della resistenza.
Lo strazio di una lunga notte di parole, di lacrime, di appelli, di promesse e di propositi senza convinzione. La mia lettera d’amore dalla terrazza della torre Montparnasse, Parigi, ritrovata dopo, sul suo comodino… Il ritorno di notte, a scapicollo. La corsa disperata all’ospedale. Le sue ultime parole come pietre. È tutta colpa tua.
Alba del 14 novembre del 1971. Tra un mese esatto avrebbe compiuto 49 anni.
Maria Jatosti
gennaio 2012
Pubblicato su L’Immaginazione, 299, maggio-giugno 2012
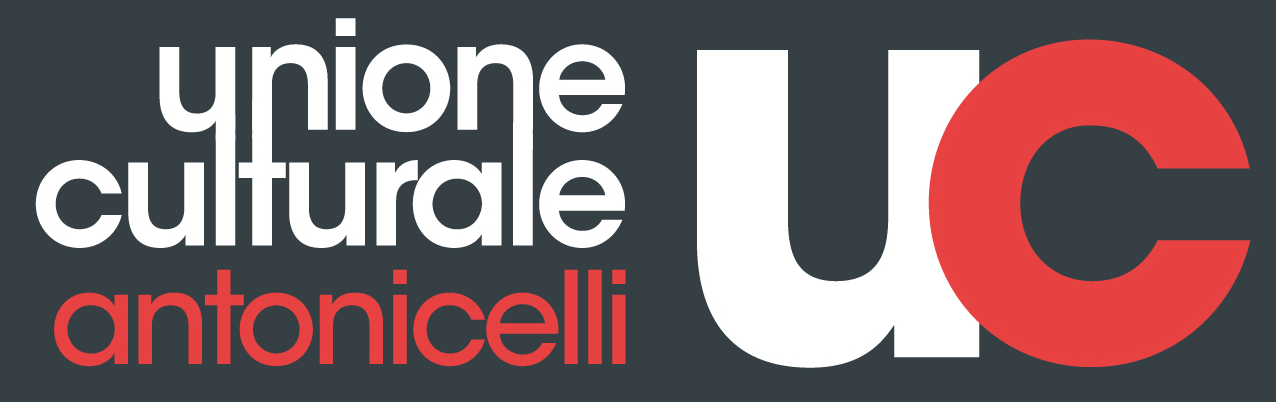

No Replies to "Bianciardi (Lavoro culturale 7)"