Si avvicina alla fine il nostro pezzo di anno bianciardiano. Lo concludiamo – per quel che vale il verbo – con due splendidi pezzi di Maria Jatosti, che di Bianciardi fu compagna.
Luciano Bianciardi, un anarchico, individualista, diffidente e sospettoso di ogni comunità costituita – ideologica, politica o letteraria – ma amico e compagno di operai, minatori, badilanti, gente povera e sfruttata della sua terra. Un anticonformista, solitario, disilluso, incline alla malinconia, alla depressione, al di là della maschera divertita, clownesca, che lo porta all’ironia, al sarcasmo, allo sberleffo e che saranno la cifra delle sue opere principali. Un intellettuale di trent’anni che, da un piccolo universo protetto, caldo, di complicità, di affetti, di speranze, viene improvvisamente sbalzato in un mondo estraneo, ostile, duro, ossessionato dalle leggi della produttività disumanizzante e del più esasperato consumismo indotto dal miracolo economico. Un provinciale toscano della Maremma trapiantato là dove pulsa il cuore dell’Italia che cambia, dentro la “capitale morale” del Bel Paese dove si sta realizzando la grande, radicale trasformazione. Sono gli anni Cinquanta, un’Italia mai “fatta” veramente, un paese contadino, miserabile, analfabeta, emigrante, bigotto, stremato dalla guerra fascista, cambia volto, diventa una nazione moderna, industriale.
Non è la rivoluzione che Bianciardi vagheggia e che configura nelle sue opere – La vita agra, soprattutto – in nome di una utopica visione di rinascita libertaria, naturale, elementare, “disattivistica e copulatoria”, come lui stesso la definisce nel suo libro maggiore. Al contrario, ciò che sta accadendo è l’esaltazione, è il trionfo della “civiltà moderna” che schiaccia l’uomo rendendolo schiavo. Schiavo del lavoro, schiavo dei valori e dei bisogni indotti dalla logica di mercato.
Trapiantato dalla sua Grosseto-Kansas City a Milano, intellettuale-a-cottimo, traduttore-operaio, mai integrato, irregolare, insofferente di regole, leggi e convenzioni, Bianciardi finirà stritolato dalla macchina infernale del cosiddetto progresso. Sconfitto e disilluso, spunterà nel veleno della satira, dell’irrisione, del sarcasmo, della rappresentazione letteraria grottesca, la rabbia, la rivolta contro una realtà preponderante e subita. Minato dai rimpianti, dalla nostalgia di un mondo idealizzato e irrimediabilmente perduto, che gli effimeri e ambigui luccichii del successo non riescono ad illuminare, costretto dalla routine del lavoro – necessità drammaticamente reale e alibi insieme -, finirà sempre più appartato, “prigioniero” in una solitudine autopunitiva e rinunciataria e si lascerà morire a soli quarantanove anni accelerando il processo di distruzione con il massiccio ricorso all’alcol. Le porte chiuse, i tappi di cera nelle orecchie, la mascherina blu sugli occhi per non vedere, non sentire, non assistere, non rendersi complice del caos e del degrado che si preannunciano e che avanzano; insomma per non esserci, come a dire: “quello che potevo fare, io l’ho fatto e non è servito a niente. Ora tocca a voi regolare i conti in sospeso”. Coi tappi di cera nelle orecchie e la mascherina blu sugli occhi, farà appena in tempo a vedere il suicidio di un amico, traduttore anche lui come lui, la strage di piazza Fontana, la morte di Pinelli, anarchico anche lui. Ma non vedrà gli anni di piombo, e neppure gli anni della “festa” craxiana, della Milano da bere; gli anni della corruzione, della confusione dei ruoli e della disgregazione morale e culturale. Gli anni del trionfo della mistificazione e dell’idiozia. Non farà in tempo a vedere il crollo delle illusioni. Il tramonto dell’Utopia.
Chissà che vita agra avrebbe scritto, oggi.
Maria Jatosti, Roma, 2006
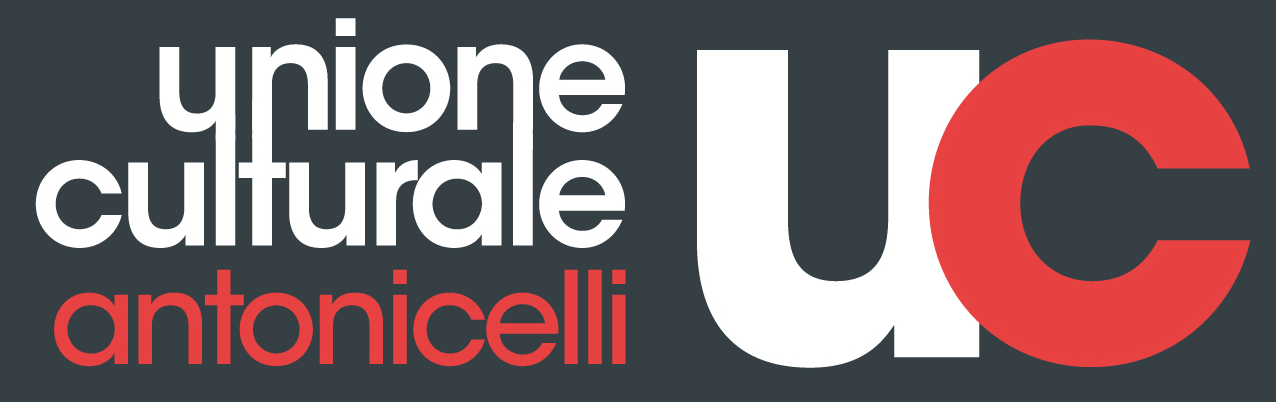

No Replies to "Un ribelle sconfitto (Lavoro culturale 6)"