Che a Torino manchi il mare, lo sanno anche i bambini. Che manchi troppo spesso l’aria – quella buona, necessaria per ossigenare neuroni, muscoli, idee e polmoni – lo sanno pure gli adulti. Colpa di un cielo basso, grigio o beige come la pelle degli abitanti e delle case. Occupato ormai da secoli, a turno, da un dio monopolista – Re, Avvocato, Banca – a cui un’intera città deve il lavoro o il potere, dunque la vita.
Il campo della cultura torinese conferma questa regola. I soldi cascano dall’alto. Sempre meno, con procedure e modalità sempre più umilianti e, soprattutto, sempre meno adatte a svolgere un lavoro culturale duraturo, incisivo, dignitoso. Da un paio di decenni domina egemone un modello di offerta culturale spettacolare, divertente, spensierata, effimera. Basata interamente sul consumo, non sulla produzione; sul godimento individuale, non sulla partecipazione attiva; riempie, in alcuni casi, alberghi, ristoranti, aeroporti, fiere, pagine di giornali, conti correnti politici e bancari. Imita, tranne rarissime eccezioni, format nazionali e internazionali. Adotta, universalmente, lessico, protocolli e valori neoliberali. Viene amministrata e impartita da personale fedele alla linea, poco importa se cooptato, apocalittico, integrato o, semplicemente, senza alternativa.
Cosa c’è che non va in tutto ciò? La gente è contenta, il potere tranquillo, i treni sono pieni e in orario. Essere per mille giorni alla guida dell’Unione culturale ha significato pormi per la prima volta questa domanda che, da privato cittadino che si calava le sue dosi annuali o biennali di svago, non mi aveva mai sfiorato. Quel che non va è che “fare cultura” in questo modo – da parte del potere e, la cosa è di importanza capitale, da parte della stragrande maggioranza del pubblico (quel 2 o 3% di torinesi che esce la sera per andare a un concerto o a una conferenza, non a un ristorante) – porta, in tempi brevi, a una distruzione della diversità, della vitalità, della tonicità culturale di una città e della sua opinione pubblica. E’ come pescare con le bombe a mano e poi lamentarsi per cosa questo comporti per il mare, i pesci e i coralli.
La cultura, persino per essere fruita in modo così seriale e mercificato, richiede menti attive, autonome, critiche. Richiede luoghi dove si svolgano attività continue, libere, sperimentali. In questi mille giorni, l’Unione culturale è tornata a essere uno di questi luoghi. Si è riempita di tantissima gente – una grande quantità di giovani, spesso nauseati dall’università – che ha trovato – in un bunker sotterraneo! – un luogo di minoranze consapevoli che cercano di fare altrimenti. Un posto che, non certo per la prima volta nella sua storia, è tornato a essere uno dei luoghi attivi di una cultura non spettacolare, né allineata. Un luogo che, per la prima volta nei suoi oltre settant’anni di storia, non ha ricevuto un solo centesimo di finanziamento pubblico da comune e regione. E che si troverà così obbligato, a partire dalla prossima stagione, a chiedere al suo pubblico di inventarsi pratiche di autofinanziamento.
Un luogo culturale che oggi, come ogni tre anni, cambia aria. Un presidente se ne va, un’altra arriva; un collettivo resta. “Una volta per sempre” recita il mantra di chi, in questa città, si impossessa di una carica. Praticare una sana ventilazione delle stanze, quando le cose vanno abbastanza bene, non quando arrivano una giunta, un fallimento o un bando a toglierti di mezzo, è gesto ovvio e scontato per chi non ha nulla di più caro nella vita che l’aria buona per respirare.
Enrico Donaggio
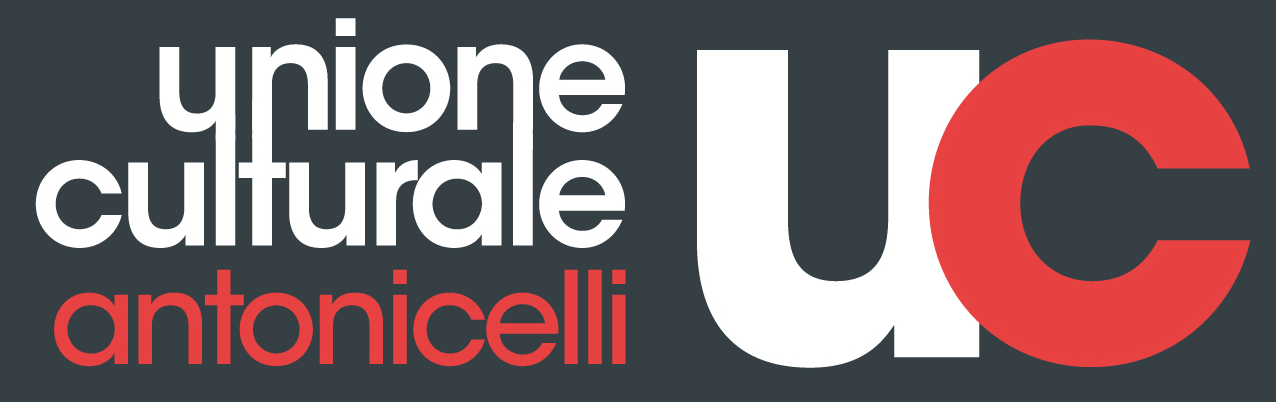

No Replies to "Cambiare aria"