
Un bel volto caparbio, occhi chiari e indagatori, sobrie le movenze, cappotto blu e taccuino di appunti sotto mano – questa è l’immagine di Franco Fortini che resta nella mente. Siamo prima di tutto il nostro corpo, ed egli si teneva riservato, in guardia, nella sua bella persona, senza concedersi alcuna eccentricità. Non si finse metalmeccanico nei cortei operai né ragazzino fra gli studenti in corsa né un quidam de populo se lo fermava la polizia. Mai si lasciò catturare da un establishment e mai si travestì da emarginato. Era stato povero, aveva tirato la vita e accumulato saperi con tenacia e diletto, sapeva di essere quel che era. Non si lasciava andare, le sue famose collere erano meditate, gli interventi brevi e mirati; non espose mai tormenti che non fossero della ragione. Salvo forse la pena dell’invecchiare: “dimmi, tu conoscevi, è vero, quanto sia indegna / questa vergogna di vecchiezza?”. Ma si stenta a credere che il male che lo afferrò nel 1993 ne abbia incrinato la disciplina. Aveva già letto per sè l’epigrafe sulla tomba di Francis Bacon al Trinity College, e titolato con il verso che la chiude l’ultima raccolta di poesie – Composita solvantur – si scomponga tutto ciò che è composto. Aveva preso la parola sempre, per sé e per gli altri, ma si appartò per morire, evento da affrontare in solitudine – “transi hospes”, “nunc dimittis” – spegnendosi sotto lo sguardo amoroso di Ruth Leiser, che per tanti anni s’era chinato accanto al suo sulla lirica tedesca.
Nel declinare del secolo e dell’esistenza gli era caduta addosso una stanchezza. Non smise di scontrarsi – era un cavallo da combattimento, sapeva di essere considerato intrattabile e con quell’ironia che si permette soltanto a se stessi s’era dipinto criniera al vento e narici frementi come i cavalli di legno delle giostre. E non c’era osso che non gli dolesse al dubitare degli esiti, non della verità, del suo pugnare – il vero, la verità, la mia verità, le nostre, ricorrono nei suoi scritti in opposizione al nulla, il niente cui gli appariva trascinato il mondo. Sentiva la rovina, provava fastidio per la sordità altrui, gli pesava l’isolamento – tutti abbiamo bisogno di consenso – ma non era disposto a transigere: la verità non è agevole, passa attraverso dure verifiche.
All’indirizzo dei molti che gli parvero sottrarsene scoccava crudeli epigrammi: eccovi là tranquilli e onorati, amici miei cari, potrei essere come voi, ma non lo sono perché sapevo la verità. Poi si pentiva dell’arroganza, e tornava su quel che aveva scritto, nulla ritirando ma riordinando e ripubblicando nel contesto della storia – non la sua, quella dei destini generali.
Una volta per sempre, mai più. Rompeva sperati dialoghi e imprese comuni – imprese di ricerca, dunque politiche, dunque di ordine morale, dunque non negoziabili. Che politica ed etica non si potessero separare era un comando della sapienza ebraica e di quella cristiana, le assumeva tutte e due. Non c’è operare lecito se non mira a un più di umanità, a che l’uomo, come scriveva ai posteri il suo amato Brecht, sia finalmente amico dell’uomo. Che la politica si riducesse alla lubrificazione del sistema del mercato non gli parve fatale, gli parve una gaglioffata. Così restava perlopiù in una solitudine orgogliosa e indolenzita. Dalla quale gettava sul mondo quel suo sguardo esigente, intollerante di mediazioni, per cui passava sempre da felici incontri a sanguinose rotture. Tutti avrebbero voluto Fortini ma nessuno alle sue condizioni.
Neppure in morte è stato consegnato con pietà alla storia. Gli onori non sono mancati ma la scena, tutte le generazioni incluse, sembra sollevata dal non sentirsene continuamente sfidata e giudicata senza amenità. Fortini giace insepolto fuori delle mura. E si spiega: ha voluto essere una voce poetica di quella parte del secolo che aveva tentato l’assalto al cielo d’un cambiamento del mondo, ha perduto ed è ricaduta fra le maledizioni del Novecento e l’inizio d’un millennio che non ne sopporta il ricordo.
Rossana Rossanda
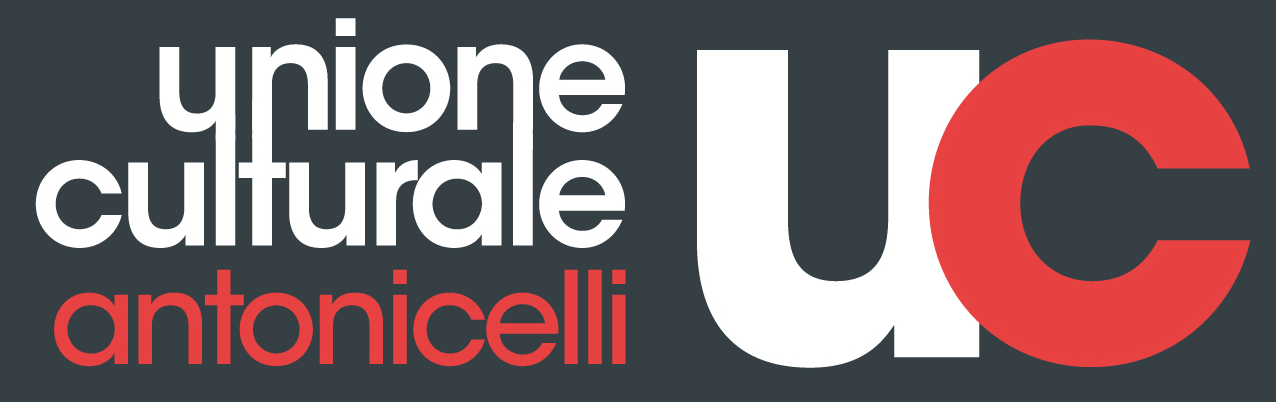

No Replies to "Extrema ratio"