Quando si riflette sull’energia che è necessario sprigionare perché si attui un cambiamento sociale radicale, occorre distinguere tre tipi di desiderio. Il primo è quello di libertà. La libertà come desiderio, come motore desiderante, come ambizione da definire. Suona ovvio, ma in realtà è molto complicato. Il secondo è molto semplice: il desiderio di cambiamento di status. Ad esempio: i neri sono oppressi e poi non lo sono più; gli omosessuali sono oppressi e poi non lo sono più. Ma questo secondo tipo di desiderio viene spesso confuso con il primo. Ho fatto parte di un collettivo di sans-papiers; dopo diversi anni, molti compagni e compagne che ancora ci militano hanno l’impressione di essere stati traditi da quelli che ottengono la regolarizzazione. Si dicono: «Merda, da quando ha preso i documenti Abdou ha lasciato il movimento» – e hanno l’impressione di essere stati scambiati per degli assistenti sociali. Ora, quel che voleva Abdou, era cambiare status, perché il suo era indegno; non voleva necessariamente cambiare la società. Qui s’intrecciano due desideri diversi. Quello del militante che lavora con i sans-papiers e quello della persona priva di documenti, che sta nella merda, che è uno schiavo. Non sono desideri identici. E tuttavia si passa la vita a confonderli, correndo il rischio di venire delusi.
Mi ricordo una scena dell’epoca della guerriglia. Stavamo di guardia in una città operaia occupata, per prevenire un eventuale attacco. Montavo dunque di guardia con Lacille, una ragazza che non vedeva i suoi bambini da non so quanto tempo; non c’era quasi da mangiare, un vero schifo. All’improvviso, sotto di noi, sentiamo che nel bel mezzo di un’assemblea qualcuno sta parlando di vacanze. Te lo riesci a immaginare? Con Lacille siamo scoppiati a ridere. Rischiavamo di venire uccisi o – cosa poi avvenuta – di essere presi, torturati a morte e sbattuti in galera. Si era prodotto un intreccio di desideri che, sul momento, mi ha fatto ridere ma sul quale, nel seguito della mia vita, ho poi riflettuto e lavorato. Quelli che parlavano di vacanze – ed era legittimo – volevano una vita più degna, diversa; mentre noi, sulla terrazza, armati fino ai denti, non avevamo lo stesso desiderio. C’era dunque stato un intreccio di due desideri differenti.
Si dà poi un terzo desiderio, anch’esso molto chiaro: il desiderio di sottomissione. Detto così sembra brutto, ma lo si capisce meglio se si pensa a un orso messo dentro una gabbia. Perfetta, ma pur sempre una gabbia. Dopo un po’ di tempo passato lì dentro, se gli apri la porta, ti accorgi che non vuole più saperne di uscire. Senza voler minimamente sminuire la «dignità umana» attraverso questo paragone con l’animale, occorre capire che la frontiera tra libertà e servitù non è mai chiara. I circuiti cerebrali dell’orso non distinguono tra «orso» e «ambiente». L’orso è per lui «orso» e «gabbia», un tutt’uno; uscire dalla gabbia significherebbe in qualche modo, per lui, cambiare identità e uscire da se stesso. È per questo che i telefoni cellulari e altre porcate del genere funzionano così bene: ti promettono che resterai sempre nello stesso circuito … Più ti identifichi con il tuo ruolo sociale, più sei preso in circuiti automatici. Ma, come nel caso dell’orso di cui abbiamo appena parlato, uscire dai circuiti automatici, lungi dall’essere una buona novella, è qualcosa che strazia. La domanda allora è questa: che fare una volta che lo abbiamo constatato?
Un organismo sociale funziona come un organismo individuale, dispiega sforzi terribili per negare che le porte della gabbia sono aperte. Gli ideologi, i nouveaux philosophes, i reazionari, i postmoderni consumano una quantità enorme d’energia per convincerci a rimanere nella gabbia. Contribuiscono allo sforzo prodotto dalla società per restare entro circuiti familiari, dal momento che non ci sono certezze sufficienti per pensare a un’alternativa chiaramente definita. Sono come un medico che dice: «Siccome non ho trovato un vaccino, passo dalla parte della malattia!». Di certo in un’epoca oscura come la nostra occorrono più coraggio e più sforzi per resistere, di quanti ne servano in un’epoca luminosa. Ma per me, che le ho vissute entrambe, l’epoca oscura è molto più interessante.
Nell’epoca luminosa non puoi evitare di diventare idiota, tutto sembra talmente semplice! Un organismo sociale, nella sua storia, ha bisogno di ambo le cose, dunque anche di epoche oscure, perché non sono tempi di pura negatività. Sono epoche di elaborazione profonda. Dopo, quando tornerà un’epoca luminosa, sappiamo bene quel che accadrà: settembre 1944, tutti contenti, tutti partigiani e resistenti – e ci si dimenticherà di noi. Ma non ce ne preoccupiamo troppo. Il nostro lavoro è scoprire come si resiste in un’epoca oscura.
La luce ha un momento che acceca. Ma è anche il simbolo del cambiamento sociale. Non è lo stessa cosa se una donna deve vivere sottomessa come una bestia da cortile o se può invece diventare un soggetto storico e sociale; se un omosessuale deve vivere nascosto o se può invece vivere una vita normale. No, non è davvero la stessa cosa. Ma il lavoro di quelli che sono morsi dal problema della liberazione è più interessante nelle epoche oscure. Bisogna smetterla di frignare. Il nostro compito, in ogni epoca, è sapere dove passa la libertà.
(Tratto da Resistere in un’epoca oscura, conversazione di Miguel Benasayag con Dominique Bellec, in É. de La Boétie, Il discorso della servitù volontaria, Feltrinelli, 2014).
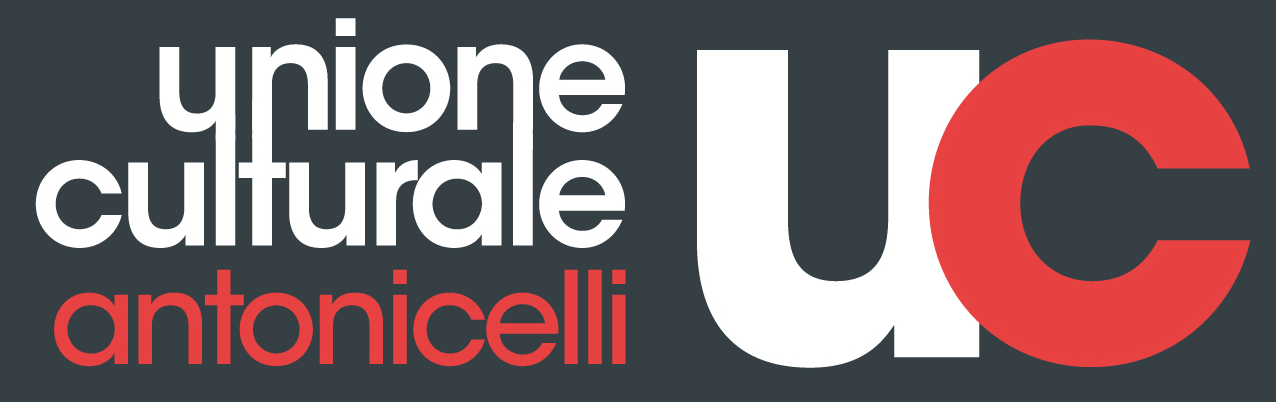

No Replies to "Liberazioni"